|
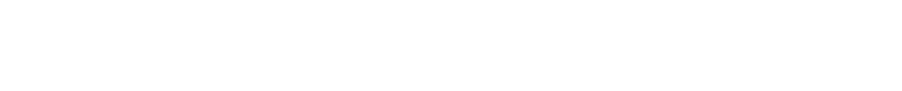
 Visita il sito Visita il sito
Il massimo rappresentante del barocco musicale nacque
in un paese della Turingia come discendente di una famiglia dedita alla
musica da almeno quattro generazioni.
Rimasto orfano di padre e di madre a dieci anni,
frequentò il liceo di Ohrdruf, ospite del fratello Johann Christoph che gli
insegnò i rudimenti della musica, ma Johann Sebastian deve essere
considerato essenzialmente un autodidatta
Egli studiò le opere dei maestri stranieri - in
particolare italiani -, venne in contatto con una vita musicale rigogliosa
che gli fece conoscere esecutori tedeschi e stranieri e lo indusse a soventi
viaggi ad Amburgo dove era in piena fioritura la scuola tedesca del
profondo nord.
Nel
1703 entra alla corte di Weimar in qualità di violinista; pochi mesi dopo
lo troviamo ad Arnstadt come organista a San Bonifacio.
Ricopre la stessa carica a Mulhausen nella chiesa di San Biagio, e a
Dombeim sposa la cugina Maria Barbara, ma nel 1708 ritorna a Weimar in
qualità di organista di corte.
Qui diviene nel 1714 primo violino nell’orchestra,
ritorna allo studio degli italiani (Vivaldi e Frescobaldi
in particolare), ma non riesce ad ottenere nel 1716 il posto di maestro di
cappella.
Un anno dopo entra con tale carica alla corte di
Cothen, dove rimane sino al 1723 (passando dopo la morte di Maria Barbara a
seconde nozze con Anna Magdalena nel 1721), e dove ha modo di dedicarsi in
particolare alla musica profana (nascono qui i Sei Concerti
brandeburghesi).
Nel 1723 si qualifica infine in qualità di Cantor e
direttore di musica a San Tommaso di Lipsia.
Qui rimarrà per il resto dei suoi giorni, non senza
spostarsi occasionalmente per inaugurare nuovi Organi, per far visita ai
figli, per tenere concerti, e nel 1747 per suonare a Potsdam alla presenza
di Federico il Grande.
A Lipsia gli impegni pratici (la scuola, la direzione
del coro e dell’orchestra, l’educazione degli allievi) lo assorbono
moltissimo, gli attriti col l’autorità locale non gli rendono la vita
facile, e anche l’ambiente familiare non è certamente dei migliori.
Eppure Bach trova il modo di scrivere una nuova
cantata per ogni settimana e di concepire alcune delle sue più colossali
creazioni nel campo della musica sacra (la Grande Messa in si minore e
altre quattro messe minori, le Passioni, l’oratorio di Natale, oltre a una
serie di composizioni minori).
Nel 1749 si fa operare agli occhi da un celebre oculista inglese, ma perde
interamente la vista e le sue condizioni generali si aggravano, tanto che
un anno dopo muore di apoplessia, mentre sta per portare a termine la
colossale Arte della fuga.
Di lui resta per tutto il sec. XVIII un ricordo
imponente più come organista che come compositore (la sua vedova finirà in
miseria nella fossa comune).
Solo nel 1802 lo storico Johann N. Forkel ne rivaluta
in un saggio l’importanza di compositore, e nel 1829 Mendelssohn
presenta a Berlino la Passione secondo S. Matteo: incomincia qui la vera,
eterna fama di Bach, che resta incorrotta e altissima a oltre due secoli
dalla sua morte.
Il suo nome verrà
onorato da molti dei suoi figli diventati musicisti, come Carl Philipp Emanuel, Friedrich
Christian, Johann Christof, Wilhelm Firedemann.
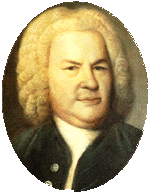
|